 Che cos’è.
Che cos’è.
Il Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) è un disturbo di natura neurobiologica. Infatti, non dipende dalla pigrizia, dal basso impegno, dalla scarsa motivazione allo studio, che spesso vengono impropriamente attribuiti ad alunni con questo genere di disturbo. Piuttosto, le persone con DSA hanno come caratteristica principale quella di essere intelligenti, ma le alterazioni di alcune microaree del loro cervello non gli permettono di funzionare altrettanto bene nei compiti di lettura, scrittura e/o di calcolo.
Il Disturbo specifico dell’apprendimento è, infatti, dominio-specifico, ovvero interessa specifiche abilità in presenza di un livello cognitivo nella norma e in assenza di deficit intellettivi, neurologici o sensoriali e con adeguate condizioni socioculturali e un’istruzione adeguata.
Imparare a leggere e scrivere è un processo semplice e praticamente automatico, tranne per chi ha un problema negli apprendimenti, come un DSA. Allora è in questo caso che c’è un bisogno più sostanziale dell’aiuto della maestra, accanto ad interventi riabilitativi mirati da parte di specialisti.
Classificazione dei DSA.
 Dislessia
Dislessia
È un disturbo che riguarda la capacità di leggere in modo rapido ed accurato in base alle attese per l’età e la classe frequentata. Può riguardare anche la comprensione del testo e quindi la capacità di cogliere il contenuto di quanto si è letto.

Disortografia
Consiste in un deficit nella competenza ortografica, in relazione al parametro di correttezza.
Disgrafia
Riguarda un’alterazione significativa del tratto grafico (grafia), che può caratterizzarsi per scarsa fluidità e scarsa fluenza.
 Discalculia
Discalculia
Consiste in un deficit a carico delle abilità aritmetiche (area del numero e del calcolo).
Come si riconosco i DSA e cosa comportano.
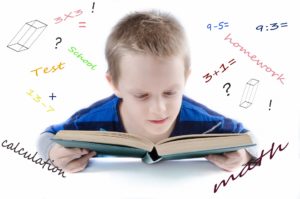 Chi ha una dislessia può:
Chi ha una dislessia può:
commettere errori di lettura, fra i più tipici citiamo la sostituzione o scambio di lettere (come ad esempio f/v, d/t, c/g, a/e, d/b, p/b, ecc); essere significativamente lento mentre legge; non comprendere il significato di ciò che ha letto.
Chi ha una disortografia può:
in generale, avere difficoltà a scrivere le parole applicando le regole ortografiche corrette. Per esempio scambia lettere, le omette o le aggiunge all’interno di una parola; usa grafemi scorretti per i gruppi consonantici (gl, gn, sc, sch, ecc); attacca alcune parole o, al contrario, separa parti di un’unica parola; omette doppie o accenti.
Chi ha una disgrafia può:
tipicamente scrivere in modo scarsamente comprensibile non solo agli altri, ma anche a se stesso. Il tratto grafico appare caratterizzato da un’alterazione significativa nella forma e nella dimensione delle lettere, nell’irregolarità degli spazi fra le lettere all’interno della parola e fra le parole. Nei casi più gravi vi è un uso alternato dello stampato maiuscolo e del corsivo. Inoltre, a volte i quaderni di bambini con problemi di scrittura sono qualitativamente “poco belli da vedere”, in quanto possono presentare “orecchie” agli angoli, copertine strappate o sgualcite, qualche scarabocchio qua e là.
Chi ha una discalculia può:
avere difficoltà nel contare scorrettamente; nel mettere in ordine una sequenza di numeri; nel leggere, scrivere e ripetere i numeri; nello svolgere un’operazione in colonna applicando le corrette procedure di incolonnamento, prestito e riporto; ma, soprattutto, nell’eseguire semplici calcoli a mente in modo rapido e corretto.
Quando richiedere una valutazione diagnostica.
 …..quando un bambino o un ragazzino presenta alcune delle difficoltà sopra descritte o, comunque, quando il suo rendimento è significativamente più basso rispetto ai compagni di classe o rispetto alle migliori prestazioni che ci si aspetterebbe per la sua intelligenza (nella norma).
…..quando un bambino o un ragazzino presenta alcune delle difficoltà sopra descritte o, comunque, quando il suo rendimento è significativamente più basso rispetto ai compagni di classe o rispetto alle migliori prestazioni che ci si aspetterebbe per la sua intelligenza (nella norma).
I dati più aggiornati ci dicono che circa il 3,5% della popolazione in età evolutiva di lingua italiana ha un DSA.
Le insegnanti hanno un ruolo importante nel comunicare ai genitori eventuali fatiche o segnali tipici riscontrati. Soprattutto se dopo un percorso di recupero individualizzato di massimo due mesi, le difficoltà permangono, allora sarà necessario fare un invio agli specialisti per la valutazione diagnostica.
La diagnosi precoce è fondamentale. La ricerca scientifica evidenzia quanto il decorso del disturbo sia migliore se viene scoperto e se si interviene nelle prime classi della scuola primaria. Persino nella scuola dell’infanzia possono esserne colti dei segnali su cui è già possibile intervenire. Quindi prima è meglio è!
 Di fatto non è mai troppo tardi! Molte persone hanno condotto il loro percorso scolastico convivendo con un DSA senza saperlo. A volte per una mancata conoscenza del disturbo, a volte perché l’insuccesso a scuola veniva attribuito a uno scarso interesse per lo studio o ad un disinvestimento o per altre ragioni, alcune persone solo in età adolescenziale o adulta richiedono una valutazione. C’è sempre tempo per migliorare la consapevolezza di sé e per dare un senso alle fatiche incontrate e che spesso hanno inciso molto anche sull’umore e sull’autostima.
Di fatto non è mai troppo tardi! Molte persone hanno condotto il loro percorso scolastico convivendo con un DSA senza saperlo. A volte per una mancata conoscenza del disturbo, a volte perché l’insuccesso a scuola veniva attribuito a uno scarso interesse per lo studio o ad un disinvestimento o per altre ragioni, alcune persone solo in età adolescenziale o adulta richiedono una valutazione. C’è sempre tempo per migliorare la consapevolezza di sé e per dare un senso alle fatiche incontrate e che spesso hanno inciso molto anche sull’umore e sull’autostima.
Affidarsi a specialisti altamente qualificati in questo campo specifico è essenziale!
Come si interviene.
L’intervento interessa principalmente tre ambiti: quello scolastico, quello riabilitativo, quello relativo al metodo di studio.
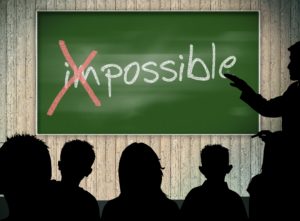 A scuola:
A scuola:
si attivano l’adozione di tutti gli strumenti compensativi e delle misure dispensative utili a promuovere le risorse dell’alunno nel percorso di apprendimento scolastico.
 In studio:
In studio:
vengono effettati uno o più cicli di trattamento riabilitativi per la rieducazione/potenziamento delle specifiche abilità deficitarie. I trattamenti di maggiore efficacia sono quelli che si basano sui più accreditati modelli scientifici e che prevedono esercizi intensivi. Inoltre, la ricerca scientifica ha evidenziato quanto importante sia intervenire il più precocemente possibile.
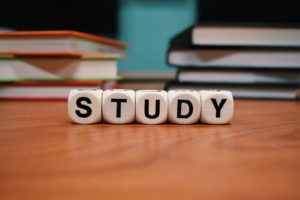 Al doposcuola specializzato:
Al doposcuola specializzato:
lo studente sperimenta ed apprende un metodo di studio basato sulle proprie risorse per compensare le proprie difficoltà, al fine di raggiungere il miglior grado di autonomia nell’apprendimento.
Copyright © 2025 © 2020
